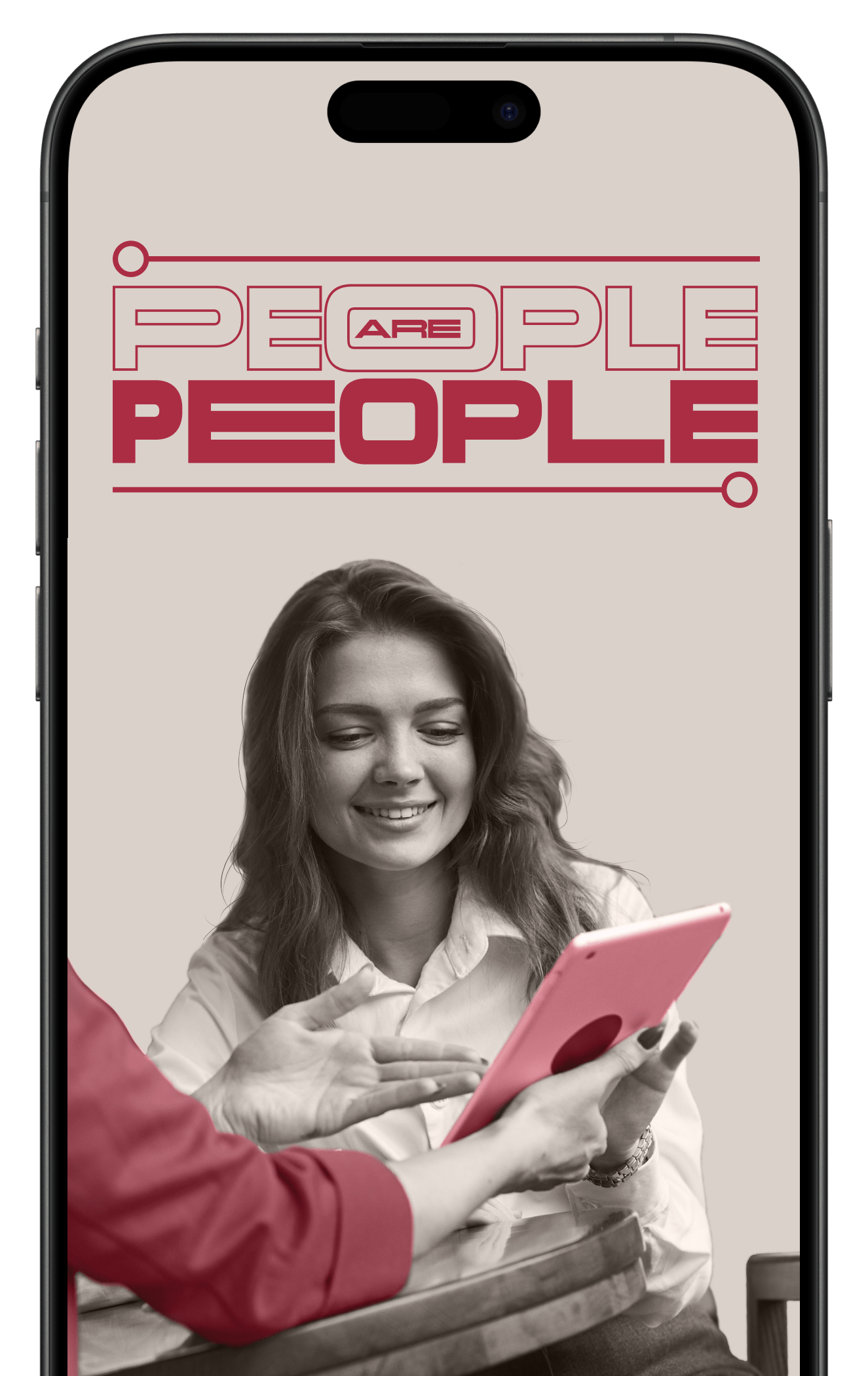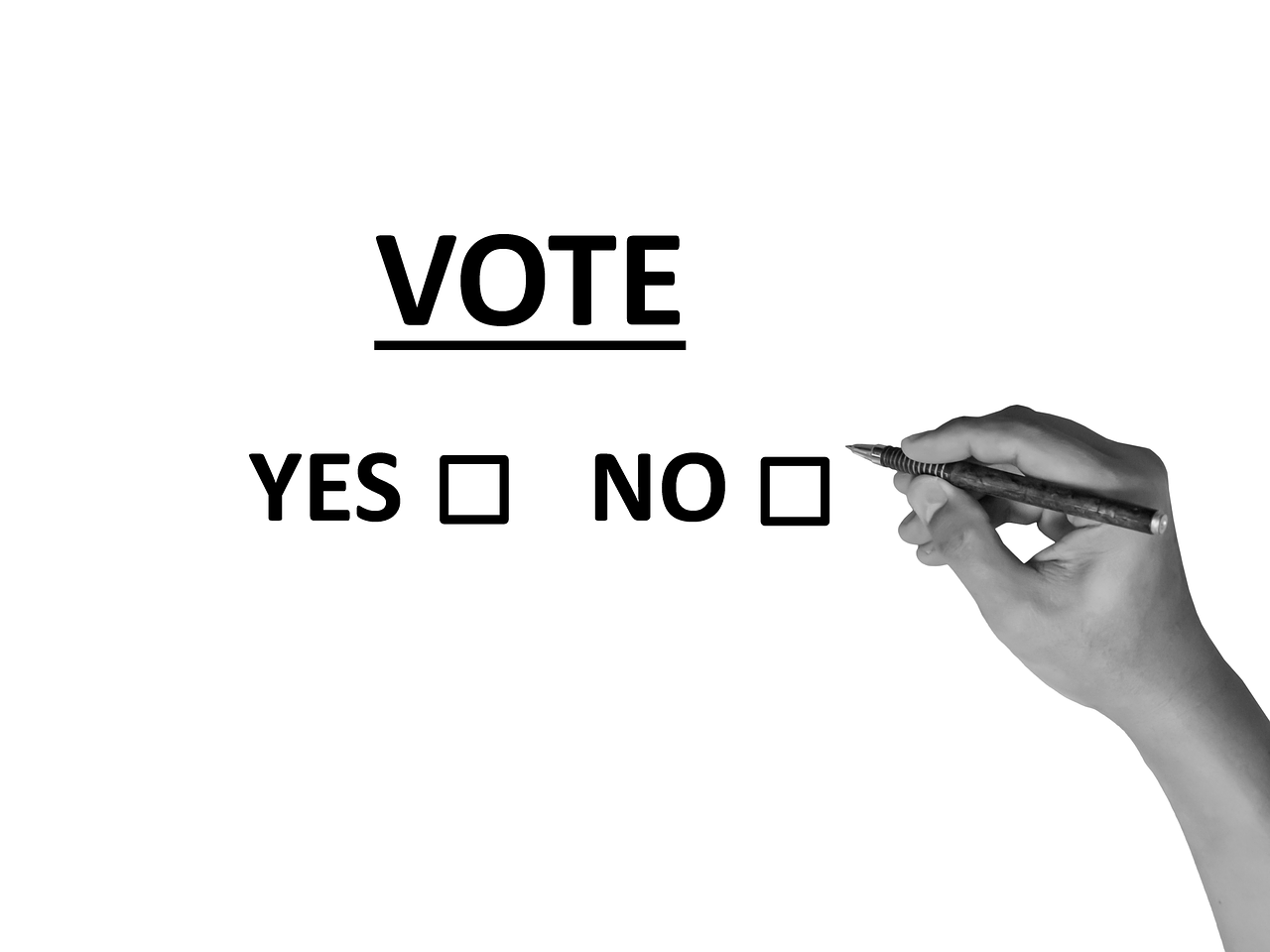Referendum: intervista al Managing Partner dello studio De Luca & Partners
Domenica 8 giugno dalle 7 alle 23 e lunedì 9 giugno dalle 7 alle 15, noi italiani siamo chiamati ad esprimere il nostro voto sull'abrogazione o meno di alcune norme in materia di lavoro e sui requisiti minimi necessari per ottenere la cittadinanza italiana per i residenti extracomunitari. Con l'eccezione del quinto quesito, abbiamo sentito che cosa ne pensa Vittorio De Luca, Managing Partner dello studio legale De Luca & Partners di Milano
Domenica 8 e lunedì 9 giugno noi italiani siamo chiamati alle urne per esprimere il nostro sì o no all’abrogazione di alcune norme in materia di contratti e sicurezza sul lavoro più un quinto quesito (scheda gialla) sul dimezzamento da dieci a cinque anni di residenza continuativa in Italia da parte degli stranieri di origine extracomunitaria che desiderano ottenere la cittadinanza nel nostro Paese. Sui primi quattro quesiti abbiamo sentito Vittorio De Luca, Managing Partner dello studio legale De Luca & Partners, la “boutique” di professionisti milanese, specializzata nel diritto del lavoro e nelle relazioni sindacali. Laureato in Giurisprudenza ed Economia, il nostro intervistato ricopre, tra gli altri ruoli, quello di membro consultivo della Commissione Certificazione della Direzione Provinciale del Lavoro di Milano, oltre ad essere socio di diverse realtà internazionali, tra cui l’Employment Lawyers Association (EELA) e l’International Bar Association (IBA).

Che cosa pensa dei primi tre quesiti referendari in materia di lavoro? Quali sono i pro e i contro conseguenti al ritorno alla normativa pre – 2015?
Partirei dal primo quesito (scheda verde, ndR), riguardante l’abrogazione del D.Lgs. n. 23/2015. Sappiamo che la riforma del 2015 era finalizzata a rendere prevedibile e correlata all’anzianità di servizio il valore dell’indennità dovuta in caso di licenziamento illegittimo e ridurre l’ambito di applicazione della tutela reintegratoria.
In realtà, la ratio che aveva ispirato l’introduzione del sistema delle cosiddette “tutele crescenti” si è totalmente persa. A seguito di interventi del legislatore e della Corte Costituzionale, si è tornati infatti ad un sistema incentrato sulla discrezionalità del giudice e sull’imprevedibilità delle sanzioni nel quale la tutela reintegratoria si è spogliata del carattere dell’eccezionalità.
Quindi ha senso votare sì in questo caso?
Pur permanendo alcune differenze con la disciplina dell’articolo 18 dello Statuto dei Lavoratori (come modificato dalla legge n. 92/2012), l’abrogazione del D.Lgs. n. 23/2015 mi sembra poco rilevante nell’ottica dell’ampliamento delle tutele dei lavoratori. Potrebbe, tuttavia, avere l’effetto utile di riunificare la disciplina dei licenziamenti illegittimi, attualmente differenziata in base alla data di assunzione dei lavoratori (ante o post 7 marzo 2015).
Che cosa pensa invece del quesito riguardante la disciplina dell’indennità risarcitoria per licenziamento illegittimo (scheda arancione)?
In primo luogo, non è legato alla disciplina introdotta da Jobs Act, bensì alla Legge n. 604/1966, nello specifico all’articolo 8 della medesima e mira ad eliminare il tetto massimo previsto per l’indennità risarcitoria in caso di licenziamento illegittimo nelle imprese fino a 15 dipendenti.
La fissazione in via legislativa di un tetto massimo per la liquidazione dell’indennità da licenziamento illegittimo, così come la sua diversa articolazione a seconda delle dimensioni del datore di lavoro, rappresenta un dato costante nel nostro ordinamento, già da prima dell’introduzione dell’articolo 18 dello Statuto dei Lavoratori e l’incertezza dei confini sanzionatori che si determinerebbe in caso di vittoria del “sì” dubito che possa giovare alla tutela dei lavoratori. Certo, se fosse vero – cosa di cui io dubito – che alcune imprese restino volutamente “sotto-soglia” per evitare l’applicazione del più pesante regime sanzionatorio per i datori di lavoro con oltre 15 dipendenti, si toglierebbe alle aziende la ragione per non crescere.
Il terzo quesito (scheda grigia) riguarda invece la questione della causale per i contratti termine sotto i dodici mesi: qual è la sua opinione al riguardo?
Innanzitutto, la disciplina del contratto a termine è stata oggetto nel corso degli anni di numerosi e costanti interventi legislativi nell’eterno dilemma se sia meglio ostacolare la stipula di contratti di breve durata per incentivare i datori di lavoro ad avviare rapporti di lavoro subordinato. Così, nel tempo, il legislatore ha cercato di bilanciare senza sosta la flessibilità per le imprese con la tutela dei lavoratori, passando da varie combinazioni di obblighi di causali più o meno rigide alla loro totale eliminazione.
A mio avviso, l’attuale regime dell’acausalità per i soli primi 12 mesi rappresenta un buon compromesso e ha la funzione – ragionevole – di invogliare i datori di lavoro ad imboccare la strada “regolare” del rapporto di lavoro subordinato imponendo, in caso di prosecuzione, l’individuazione di un motivo o la stabilizzazione. Quest’ultima ipotesi, peraltro, è tutt’altro che infrequente, posto che un datore di lavoro che ha formato un lavoratore, investendo su di lui, più facilmente tenderà a stabilizzarlo passando ad un contratto a tempo indeterminato. Ciò che è certo, invece, a prescindere da quanto sopra, è che la stretta sui contratti a termine che deriverebbe dalla vittoria dei “sì” porterà nuovamente ad un incremento del contenzioso e ad aumentare il riscorso a contratti atipici ancor meno favorevoli per i lavoratori.
In caso di mancato raggiungimento del quorum e/o di vittoria dei no, a suo avviso su quali riforme dovrebbe puntare la legislazione italiana per rendere comunque più omogenea la disciplina dei rapporti di lavoro a tempo determinato? E in generale: la disciplina sui contratti di lavoro è adeguata alle esigenze del mercato del lavoro attuale?
Come detto, ritengo che l’attuale regolamentazione rappresenti già una soluzione bilanciata e ragionevole che, senza togliere tutela ai lavoratori, tiene conto delle esigenze fisiologiche di flessibilità delle imprese.
Trovo, invece, che sia un peccato che negli anni si sia abbandonato il sistema che aveva provato ad introdurre Matteo Renzi con il D.Lgs. n. 23/2015.
Perché lo pensa?
In un’economia che è diversa da quella degli anni ’70 la reintegrazione non è più uno strumento adatto. Peraltro, si omette spesso di considerare che, nella quasi totalità dei casi, i primi a non volere la reintegrazione sono proprio i lavoratori che dopo essere stati estromessi dall’azienda optano per l’indennità risarcitoria piuttosto che per la reintegrazione. I casi concreti di reintegrazione sono davvero limitati. L’originario sistema delle “tutele crescenti”, caratterizzato da regole certe con prevedibilità dei costi sia per l’azienda che per i lavoratori è, peraltro, in linea con i sistemi di altri paesi (quali Germania e Spagna). A prescindere dall’esito dei referendum, in ogni caso auspico un intervento del legislatore che porti ad una armonizzazione del sistema delle tutele per il caso di licenziamento.
Qual è la sua opinione da giurista in merito al quesito sulla responsabilità solidale negli appalti (scheda rosa)? Intravvede qualche contraddizione rispetto alla normativa introdotta dal nuovo Codice o sarebbe invece una via per sanare un vulnus nello stesso?
L’estensione della responsabilità solidale del committente per i danni conseguenza dei rischi specifici propri dell’attività dell’appaltatore rappresenta l’ultimo tassello per una piena responsabilità del committente verso i lavoratori dell’appaltatore. L’eccezione prevista dalla norma vigente si spiega per l’impossibilità di un effettivo controllo su lavorazioni le cui caratteristiche impediscono o rendono quanto meno difficile un reale controllo da parte dell’appaltante.
In ogni caso, il numero degli infortuni sul lavoro anche gravi dimostra che il problema è oggi ancora irrisolto. A mio avviso, per prevenire gli infortuni, l’unica soluzione è quella di incrementare i controlli da parte degli Ispettori del lavoro.
NEWS CORRELATE