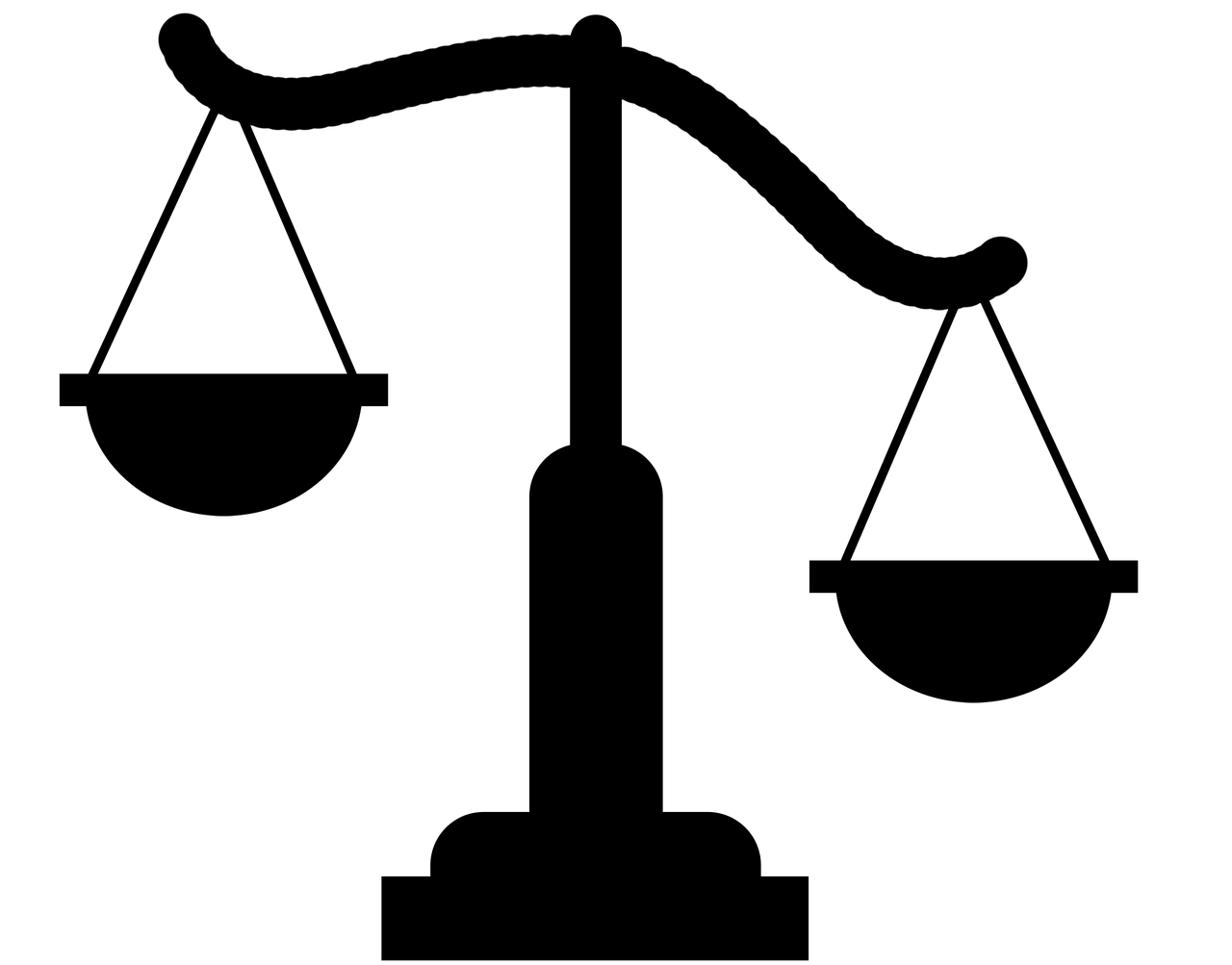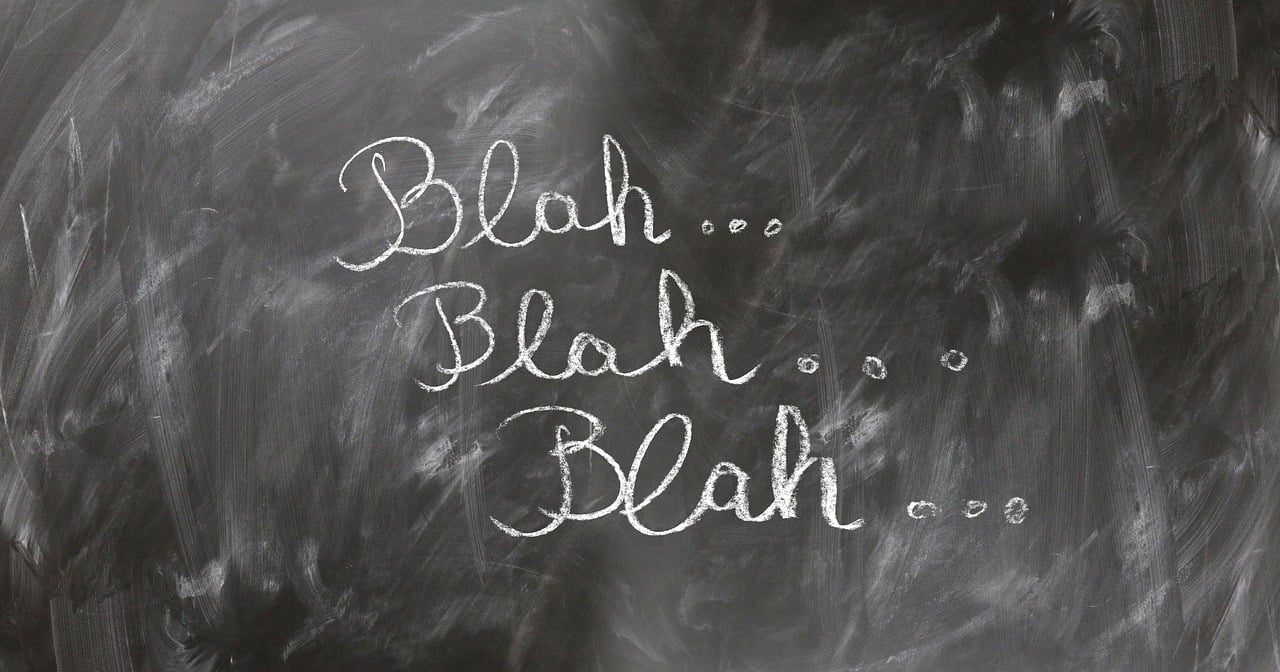Persone, reskilling, innovazione e fiducia: le parole chiave del lavoro secondo Randstad
Nella nostra intervista Annalisa Bonifacio, Randstad Enterprise Director, racconta l'evoluzione del mondo del lavoro dall'anno del suo ingresso nella talent company internazionale avvenuto nel 2006
Prima il Covid, poi l’intelligenza artificiale generativa: gli anni Venti del XXI secolo si apprestano ad entrare nel secondo quinquennio dopo un’accelerazione subita dal mondo del lavoro senza precedenti. Ne sanno qualcosa in Randstad, la talent company internazionale che accompagna da tempo le transizioni sociali ed economiche dell’Occidente. Tra i testimoni che hanno vissuto in diretta i cambiamenti sopra descritti c’è anche la protagonista della nostra intervista, Annalisa Bonifacio, Randstad Enterprise Director, che guida la divisione che si occupa di talent strategy rivolta alle organizzazioni e alle persone.

Annalisa, lei è arrivata in Randstad nel 2006: com’è cambiato il suo ruolo da allora?
«Premettendo che la nostra è un’azienda in cui si può restare a lungo ma senza necessariamente fare le stesse cose, ho cominciato con quello che è il nostro core business, quindi sono passata dalla filiale occupandomi di selezione e gestione del personale. Poi ho avuto l’opportunità di vivere l’HR dall’interno con i nostri progetti di outsourcing, in cui i nostri consulenti vengono “prestati” alle aziende clienti per occuparsi proprio di risorse umane. Da lì mi sono avvicinata alla parte forse meno nota della nostra realtà, quella della consulenza, con quale tocchiamo tutti gli aspetti della strategia delle persone in azienda: dall’employer branding e l’attrazione dei talenti, fino alle transizioni interne-esterne, quindi all’outplacement e ai servizi che supportano anche questi passaggi».
Vi occupate anche di sviluppo e formazione?
«Sì, in tutte le loro forme. Siamo infatti partiti dai talenti della nostra società – i lavoratori somministrati a tempo determinato e indeterminato – ma oggi ci occupiamo anche dei talenti dei nostri clienti. Siamo un osservatorio che ci permette di seguire tutte le fasi del ciclo di vita delle persone in azienda, sapendo che spesso, nella stessa conversazione con il cliente, si passa dal “devo attrarre” al “devo sviluppare” al “devo ricollocare”. Dare al cliente un unico partner che può seguire il suo bisogno che spesso è complesso e fatto di fasi. Oggi, in Randstad Entreprise, siamo quasi 500 colleghi che si occupano di consulenza in outsourcing, formazione, coaching e outplacement».
Quindi avete diverse specializzazioni e un ambito “enterprise”: ci spiega in cosa consistono le une e l’altro?
«Le “specializzazioni” ci permettono di parlare sempre di più la lingua dei nostri clienti. Ci sono ad esempio i colleghi di Randstad Operational, più vicini al mondo produttivo e operative. Poi ci sono le specializzazioni Randstad Professional orientate verso il mondo dei white collar, e inoltre, ci sono i colleghi di Randstad Digital, che seguono in modo specifico i profili legati al mondo ICT.
Quando parlo di “Enterprise” mi riferisco invece al mondo della consulenza all’interno di Randstad a livello globale. Noi, come società di consulenza, supportiamo gli altri colleghi e i clienti proprio per entrare su tematiche più consulenziali, strategiche, legate alle persone».
Quanto è centrale per voi il lavoro di ricerca per capire come si orientano i candidati, verso quali settori e professioni?
«Nel tempo, sempre di più, perché ci serve come bussola strategica da offrire alle organizzazioni. Il Randstad Workmonitor, ad esempio, è arrivato alla sua ventiduesima edizione. Si tratta di uno studio che raccoglie opinioni, ambizioni e aspettative dei lavoratori in 35 mercati nel mondo».
Qual è la sua finalità principale?
«Grazie a questo tipo di indagine siamo in grado sia di confrontare mercati e realtà diverse, sia di misurare il divario tra le aspirazioni dei talenti e ciò che le aziende offrono realmente. Così capiamo che cosa cercano le persone: non solo come sviluppare le proprie competenze, ma, sempre di più – soprattutto per le generazioni più giovani – anche il perché e il chi dell’azienda».
Perché contano così tanto queste domande?
«Avere un senso di comunità, sapere chi sono le persone dentro le organizzazioni è un fattore determinante, ce lo dicono chiaramente i talenti. A partire da qui lavoriamo su come cambiano le competenze, ma con un occhio costante alle aspettative».
Quindi che cosa dicono gli ultimi Workmonitor in merito alla più pressante richiesta di work life balance da parte soprattutto della Gen Z? E’ condivisa anche dai giovani di altri Paesi?
«Assolutamente sì. Il desiderio di qualità della vita guadagna terreno, pur senza annullare la ricerca della stabilità economica. Sono invece dimensioni che devono convivere. Il work life balance è declinato in vari modi, ma per i talenti delle giovani generazioni non c’è solo la flessibilità, bensì anche l’allineamento su valori e aspirazioni. È una generazione che si aspetta di essere ascoltata e di vedere coerenza tra ciò che l’azienda dichiara e ciò che fa. Questo però non significa che l’aspetto retributivo o la stabilità non interessino più: la stabilità economica resta fondamentale, anche in relazione all’aumento dei salari e all’inflazione. Semmai si parla molto di più di retribuzione equa. Inoltre, l’equilibrio vita-lavoro è un driver importante sia per chi rimane sia per chi decide di cambiare lavoro. Si tratta in definitiva di un criterio di scelta diventato determinante a livello globale per fidelizzare e prevenire un turnover eccessivo».
Ci sta dicendo in altri termini che non è vero che ai giovani interessa solo il privato quando chiedono maggiore equilibrio vita – lavoro?
«Esatto. I giovani sono molto interessati ai valori delle aziende e al loro impatto sulla società. Per questo lavoriamo tanto sull’employer branding: le aziende devono diventare più capaci di comunicare, usando linguaggi e canali che i candidati più giovani si aspettano. Bisogna insomma tenere insieme più aspetti: benessere, equilibrio, valori, impatto sociale. I ragazzi vanno a vedere che cosa fa davvero l’azienda, che contributo dà al cambiamento della società, quanto è coerente con ciò che dichiara».
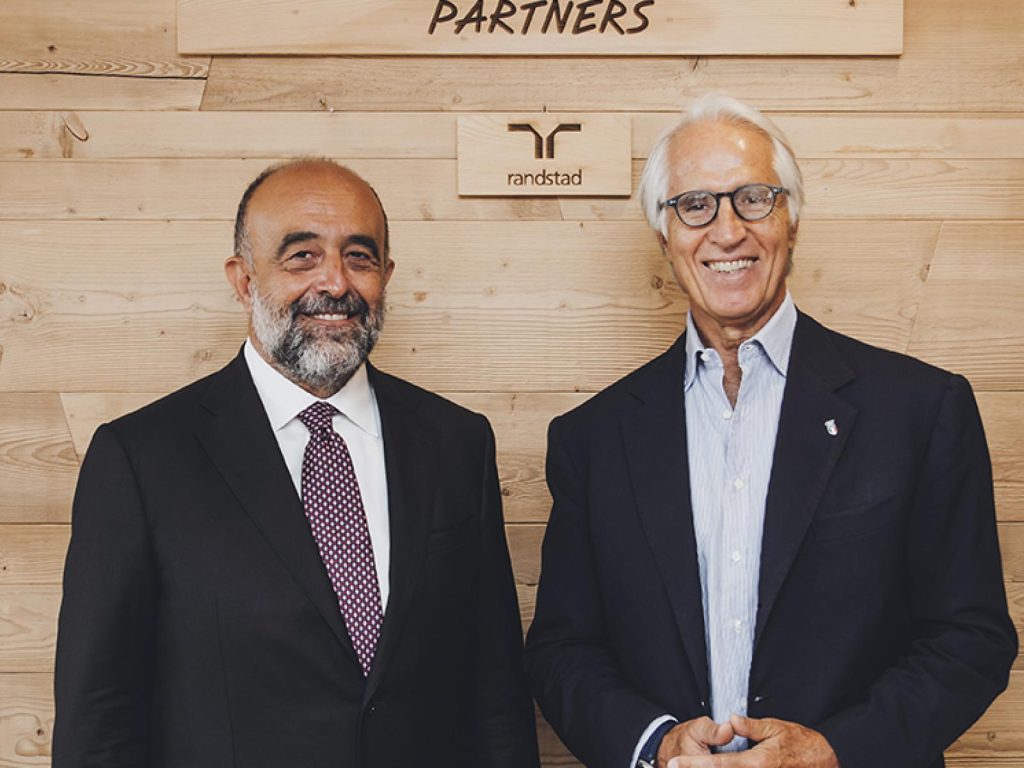
Perché Randstad ha scelto di essere partner dei Giochi Olimpici e Paralimpici Invernali e, più in generale, così vicina al mondo dello sport?
«La nostra strategia di essere Partner for Talent in Milano Cortina è un buon esempio del nostro posizionamento. Il legame della nostra realtà con i valori dello sport nasce infatti ancora prima di questa partnership: da molti anni abbiamo relazioni con diverse realtà sportive, con cui costruiamo strategie insieme».
Qual è la vostra visione dello sport?
«Secondo noi lo sport è un veicolo eccezionale per raggiungere il talento, ma non solo: se vogliamo parlare di valorizzare e sviluppare il talento, la metafora sportiva rispecchia i nostri valori e la nostra missione. In particolare, la partnership con Fondazione Milano Cortina 2026 è un progetto molto importante per noi, iniziato nel 2022, fin dall’avvio del percorso. Ci occupiamo di affiancare l’organizzazione su tutti i temi di reclutamento, formazione e ingaggio del personale. In questo caso essere partner strategico del cliente si è concretizzato in modo evidente, perché parliamo di un’organizzazione creata ad hoc, molto interessante da un punto di vista HR, in più legata al mondo sportivo».
Che tipo di figure avete reclutato per Milano Cortina e come si è sviluppato questo lavoro?
«Nella prima fase si è trattato di selezionare tutte le persone che hanno lavorato alla preparazione: di fatto, la creazione di una vera e propria azienda temporanea per arrivare pronte al momento unico dell’evento. Negli ultimi mesi sono entrati in gioco colleghi di tutte le specializzazioni di Randstad, perché si lavorerà su una serie di talenti più temporanei. I valori dello sport – la dimensione universale, la componente emotiva, i valori condivisi – hanno facilitato la collaborazione e reso naturale questo lavoro comune».
Lo sport è anche una metafora che usate nella formazione manageriale. In che modo?
«Per parlare di obiettivi, di lavoro di squadra, di performance è molto naturale se si parte dallo sport. Se la metafora non viene banalizzata, ma usata bene, può diventare uno specchio potente di temi che si trasferiscono facilmente al mondo aziendale».
Torniamo sul benessere organizzativo: in particolare su parole come burnout, job hopping e le molte paure legate all’ingresso dell’IA nelle nostre vite: come affronta Randstad tutte queste sfide globali?
«Sono temi su cui lavoriamo in costante confronto con gli altri Paesi. Spesso vengono vissuti come aspetti contrastanti – ad esempio flessibilità e stabilità, benessere e pressione competitiva – e proprio questo ci dice che, in sfide così complesse, serve un approccio strategico. La nostra risposta, a tutte le latitudini, è mettere sempre al centro l’essere umano. Applicando quest’ottica al benessere e al burnout, partiamo dal fatto che oggi le aziende hanno il dovere di prevenire lo stress lavoro-correlato e di promuovere benessere con programmi dedicati, flessibilità e vari tipi di supporto. Serve un ambiente che favorisca l’ascolto e manager capaci di riconoscere per tempo situazioni di disagio».
Cresce la sensibilità su questi temi, a suo avviso?
«Sì, anche perché le ricerche ci dicono che circa un terzo dei candidati in Italia dichiara di sperimentare spesso stress e burnout: sono dati significativi, che preoccupano e di cui le aziende devono farsi carico. Parallelamente resta la voglia di migliorarsi, cambiare, restare occupabili nel lungo periodo. Dopo il Covid la mobilità si è un po’ ridotta, ma continua, e le persone vogliono capire meglio le proprie competenze. Di nuovo, parliamo di dimensioni che devono restare flessibili: accompagnare, ascoltare, mettere la persona al centro per renderla più forte nel mercato del lavoro».
Di quali competenze avrà bisogno l’umanità, al di là delle rivoluzioni tecnologiche prossime venture?
«L’innovazione fa parte della nostra natura: prima c’è stata la macchina, poi internet, ora l’intelligenza artificiale. Non crediamo che si tratti di minacce da cui difendersi, ma di strumenti che richiedono nuove competenze per essere governati in modo etico e responsabile. Possiamo parlare di due grandi famiglie di competenze, che devono dialogare sempre di più. Da una parte ci sono le competenze tecniche e digitali: tutto ciò che riguarda l’IA, la data analysis, i big data, e in generale le skill tecniche che oggi sono richiesti in ogni settore e professione. Dall’altra parte – ed è una buona notizia per noi umanisti – c’è quasi un ritorno alle competenze umane o trasversali. In un’era di grande automazione, riportiamo l’attenzione su quelle capacità che generano valore nell’esperienza e non sono delegabili: pensiero creativo, leadership, autoconsapevolezza, flessibilità, agilità, pensiero analitico. Un’attenzione particolare va infine al potenziale di apprendimento, ossia quanto le persone che entrano in azienda, o che ci sono già, hanno voglia di imparare e disimparare. In questo contesto la capacità di rimettersi in gioco è cruciale».
Ha usato una parola chiave: fiducia. Che ruolo ha per Randstad e nel vostro lavoro con i giovani?
«“Fiducia” è una parola a cui teniamo moltissimo e non è un caso. “To trust” è uno dei valori fondanti di Randstad fin dalla nascita. Noi crediamo che i valori non siano semplici slogan da mettere sui manifesti o scrivere sui muri: quando sono davvero legati alla cultura organizzativa, alle persone e ai loro comportamenti, diventano bussole che orientano il lavoro quotidiano. Incontriamo moltissimi giovani nelle nostre attività di orientamento, che oggi sono fondamentali. Cerchiamo di trasmettere fiducia nel futuro con consapevolezza e realismo, ma con uno sguardo di speranza. Mettendo la “saggezza umana” al centro pensiamo che ci sia una buona strada per affrontare il mondo del lavoro in modo più equipaggiato».
Veniamo a un tema spesso delicato: come si fa un “buon” outplacement? Quali sono le vostre parole chiave?
«La prima è sicuramente reskilling. Molto spesso il lavoro cambia intorno alle persone: ci sono business che si trasformano, competenze che diventano meno aderenti alle nuove strategie. In questi casi le aziende fanno delle valutazioni su quali profili servano davvero per il futuro. Il nostro lavoro non è diverso da quanto abbiamo detto finora: ascolto e comprensione. Si tratta di capire le persone che stanno vivendo una transizione e, quando possibile, di aiutarle a restare in azienda. L’attenzione al talento interno è una delle tendenze più importanti del momento: evitare l’automatismo “una persona esce, ne cerco subito un’altra fuori”».
Come agite per favorire il reskilling?
«Accompagniamo le persone con strumenti come il coaching e, in alcuni casi, con sportelli di counseling. Servono per conoscerle meglio, ascoltarle, capire se – magari grazie anche a percorsi formativi – c’è ancora spazio per restare utili e produttive all’interno dell’organizzazione».
E quando invece l’incontro persone aziende non è più possibile come agite?
«In quei casi diventa essenziale accompagnare bene le persone all’esterno. In molte aziende italiane ci sono lavoratori che sono rimasti oltre 20 anni nello stesso posto: è comprensibile che non conoscano più bene il mercato, i canali, le modalità più corrette per riposizionarsi. Lavoriamo pertanto in modo molto pratico e vicino: esploriamo insieme il mondo del lavoro, come funziona oggi, come ci si presenta, ci si allena a “tornare sul mercato”. È un modo concreto per restituire fiducia a lavoratori disorientati, che possono trovare un’altra strada, magari migliore della precedente. Capita anche che persone “strette” dal cambiamento – non sempre scelto – scoprano risorse, aspirazioni e talenti che avevano accantonato in fasi precedenti della vita. Questo vale anche per chi si trova, magari oltre i 50 anni, a dover ricominciare da capo: succede, e proprio per questo l’accompagnamento diventa ancora più importante».
NEWS CORRELATE