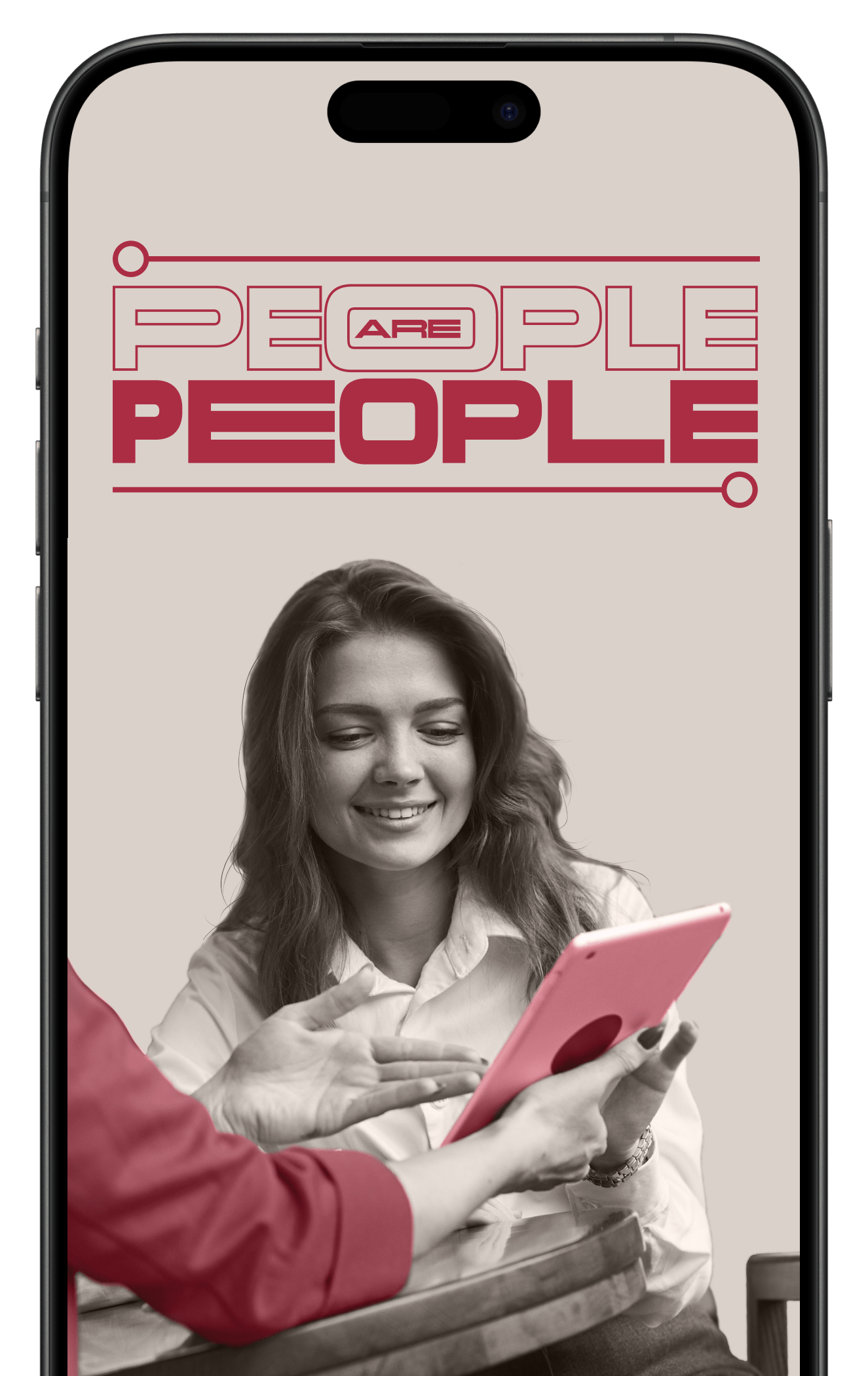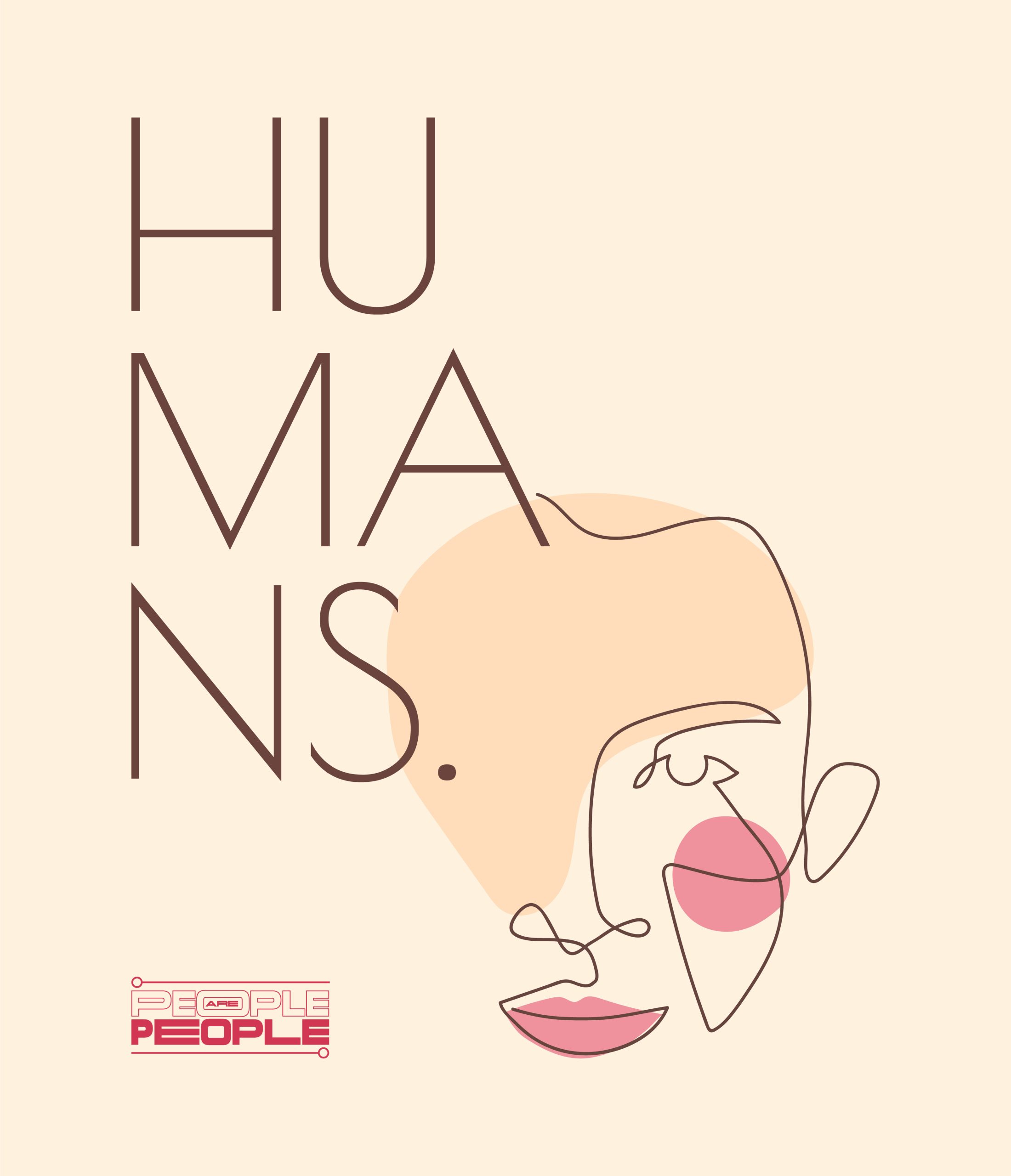
Dal multitasking al monotasking: quando meno diventa di più
Nel nuovo articolo, il contributor Franco Zullo spiega perché la pratica di svolgere più mansioni in contemporanea, dilagante ormai in molti tipi di professioni, sia la prima causa di stress e burnout con effetti molto negativi anche sulla qualità finale del nostro lavoro. La buona notizia è che invertire la rotta è possibile, come racconta l'autore anche nel suo libro in uscita a fine anno.
di Franco Zullo*

«Mentre mi scrivevi stavo riascoltando un’intervista da montare. Intanto arrivavano altre mail… ma per noi giornalisti è normale: siamo sempre un po’ sott’acqua».
Chi parla è Gina, una giornalista, che con poche parole ha sintetizzato una condizione ormai diffusa in quasi ogni professione: essere sempre connessi, sempre attivi, sempre in affanno.
Non si tratta solo di carichi di lavoro crescenti o di organici ridotti — è un modo di vivere e di lavorare che sembra essersi radicato come se fosse inevitabile.
Eppure, dietro quella parola così apparentemente positiva — multitasking — si nasconde una delle principali cause di stress, dispersione mentale e perdita di efficacia nel lavoro contemporaneo.
Il mito dell’efficienza che consuma energia
Spesso accade nella nostra mente che saper fare più cose contemporaneamente sia sinonimo di efficienza. Ma le neuroscienze raccontano tutt’altro: il cervello non lavora in parallelo, ma in sequenza. Ogni volta che cambiamo attività, anche solo per rispondere a una notifica o controllare una mail, il nostro sistema cognitivo ha bisogno di tempo per riavviarsi.
Si chiama switching cost — il costo del passaggio mentale tra un compito e l’altro. E secondo numerosi studi riduce la produttività personale fino al 40%.
In pratica, in una giornata di otto ore, ne perdiamo più di tre in interruzioni, dispersione e riadattamento.
Non è un caso se, a fine giornata, molti di noi si sentono esausti, ma insoddisfatti: abbiamo fatto tanto, ma non ciò che contava davvero.
Sempre online, mai davvero presenti
Viviamo in una condizione di iperstimolazione permanente. Chat, riunioni, aggiornamenti, piattaforme di collaborazione, social: tutto reclama attenzione. Ma ogni “ping”, ogni micro–interruzione, è una goccia che scava la nostra capacità di concentrazione.
La Harvard Business Review lo definisce “digital exhaustion”: stanchezza cognitiva da iperconnessione.
Si manifesta con calo di memoria, distrazione costante, stress emotivo e una sensazione diffusa di non riuscire mai a staccare del tutto.
Eppure, invece di rallentare, acceleriamo. Rispondiamo più in fretta, apriamo più finestre, ci connettiamo a più piattaforme. Come se, saturando ogni momento, potessimo ritrovare controllo.
Ma ciò che otteniamo è l’effetto opposto: una presenza parziale, frammentata, ansiosa.

Ti è mai capitato di leggere tre volte la stessa riga di un testo senza ricordarla?
Di uscire da una riunione senza sapere cosa si è deciso? Di controllare il telefono “solo un attimo” e accorgerti che sono passati venti minuti?
Non è mancanza di volontà. È un sistema che esaurisce l’attenzione come fosse una risorsa infinita.
Non è solo questione di tempo. È questione di energia.
Spesso pensiamo di avere un problema di gestione del tempo, ma ciò che realmente manca è la gestione dell’energia. Il cervello consuma oltre il 20% dell’energia totale del corpo: ogni decisione, ogni cambio di focus, ogni interruzione ci costa qualcosa.
- Quando l’attenzione si frammenta, cala la qualità del pensiero.
- Quando cala la qualità del pensiero, aumentano gli errori.
- E quando aumentano gli errori, aumenta anche lo stress.
- È un circolo vizioso che porta alla stanchezza mentale cronica.
- E non si risolve lavorando di più — ma lavorando diversamente.

L’AI come alleato (ma non come soluzione magica)
Molti professionisti stanno scoprendo nell’intelligenza artificiale un modo per alleggerire i carichi ripetitivi: organizzare testi, rispondere alle mail, sintetizzare dati. È un passo importante, ma non sufficiente.
L’AI può restituirci tempo solo se impariamo a usare meglio noi stessi: a stabilire priorità, a delimitare spazi di concentrazione, a creare routine sane. Altrimenti, finisce per diventare l’ennesimo strumento che ci tiene più connessi, più performanti e più esausti.
L’arte di sottrarre
Il lavoro del futuro non richiederà solo nuove competenze digitali, ma soprattutto nuove competenze umane: lucidità, equilibrio, presenza.
Saper eliminare ciò che è superfluo sarà la vera abilità strategica.
Ridurre riunioni inutili, spegnere le notifiche per un’ora, organizzare la giornata in blocchi di lavoro concentrato (il cosiddetto Deep Work), concedersi pause di rigenerazione cognitiva: piccoli gesti che possono rivoluzionare la qualità della nostra produttività.
Non si tratta di semplificare per comodità, ma per necessità.
Perché in un mondo complesso, la semplicità è una forma di intelligenza.
Dal multitasking al monotasking consapevole
Imparare a dedicarsi a una cosa alla volta non significa tornare indietro, ma andare avanti con maggiore consapevolezza. Il monotasking non è statico bensì intenzionale.
È scegliere di essere pienamente presenti in ciò che si fa, anche per poco tempo, ma con qualità e concentrazione totale.
In molti contesti, le organizzazioni più innovative stanno già sperimentando modelli che premiano l’attenzione anziché la reperibilità: settimane lavorative più corte, giornate senza meeting, spazi digital-free.
I risultati? Maggiore soddisfazione, creatività e focus, con performance uguali o superiori.
Dal problema alla soluzione: il metodo per ritrovare equilibrio
Riconoscere il problema è il primo passo, ma serve anche un metodo per cambiarlo.
È da questa esigenza che nasce il mio prossimo libro, SMARTER, in uscita a fine 2025: un percorso che integra neuroscienze, gestione dell’energia e strumenti concreti per trasformare stress e dispersione in focus e performance sostenibile.
Non si tratta di fare di più, ma di imparare a fare meglio. Di comprendere come il cervello, il corpo e l’ambiente di lavoro possono essere riallineati per restituirci ciò che spesso perdiamo: chiarezza, energia, tempo di qualità.
L’approccio SMARTER propone un equilibrio tra tre dimensioni che dovrebbero sempre coesistere: produttività, benessere e performance. Solo quando queste si integrano, il lavoro torna a essere una forma di realizzazione e non di esaurimento.
Forse la vera sfida non è il lavoro in sé, ma il modo in cui lo viviamo
In fondo, non è la quantità di attività che definisce il nostro valore, ma la qualità della nostra attenzione.
Essere sempre raggiungibili non significa essere realmente presenti.
Forse non servono giornate più lunghe, ma giornate più piene di senso.
E forse il successo, oggi, non è fare tutto, ma scegliere bene cosa vale la pena fare.

Allora chiediamoci:
– quante delle cose che riempiamo di urgenza hanno davvero valore?
– Quanto tempo passiamo a reagire invece di agire?
– E cosa accadrebbe se, anche solo per un’ora al giorno, ci concedessimo il lusso del silenzio, della concentrazione, del pensiero profondo?
Forse scopriremmo che la vera produttività non nasce dall’accelerazione, ma dalla presenza.
E che il futuro del lavoro — e di noi stessi — dipende da quanto sapremo semplificare per evolvere.

*Chi è l’autore
Strategic Advisor per CEO, HR e Team Leader, da oltre 20 anni Franco Zullo supporta le organizzazioni nel ripensare i modelli di lavoro e di business per migliorare performance, produttività, benessere e impatto. È autore e speaker internazionale su temi legati al futuro del lavoro, alla strategia della performance e alla trasformazione sistemica delle imprese. Il suo approccio combina visione strategica, pensiero sistemico e innovazione centrata sulle Persone. Appassionato di vela, cibo & vino, musica, viaggi e delle persone diverse da lui che incontra lungo il cammino.
NEWS CORRELATE