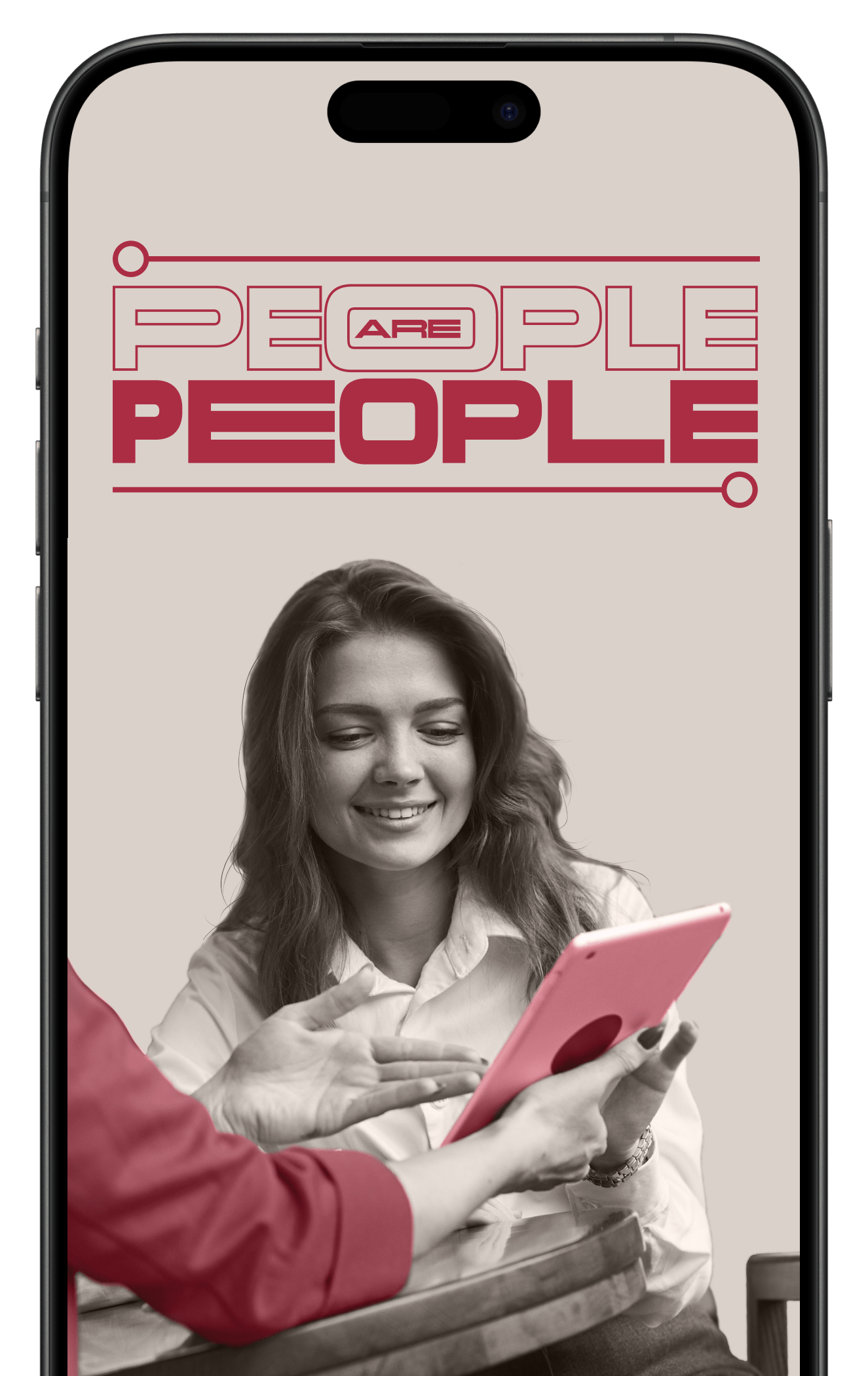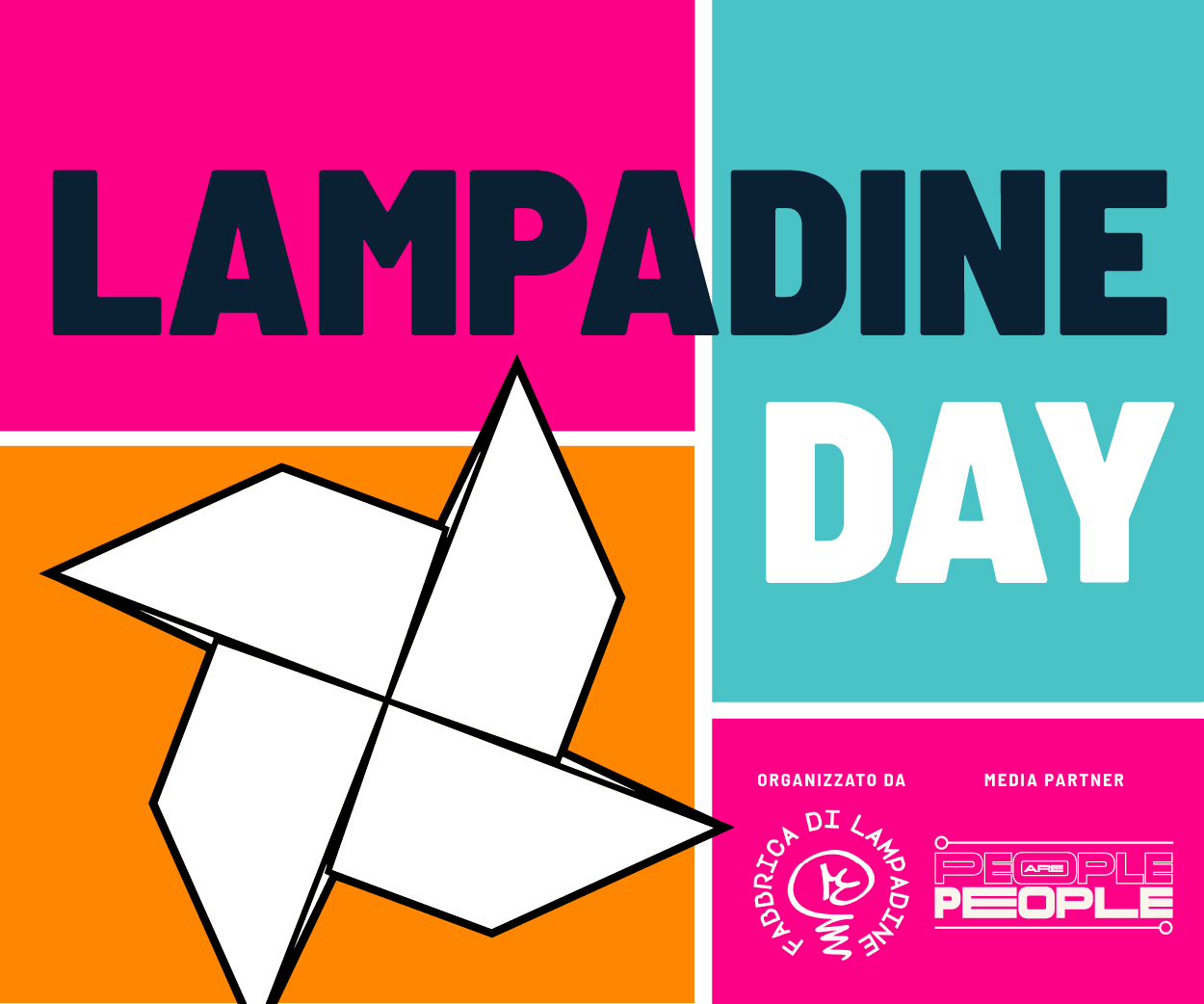Cara azienda, se mi rispetti, chiamami con il mio alias
La carriera alias è uno strumento di inclusione che permette alle persone nate con un genere e con un nome nei quali non si riconoscono di vivere negli ambienti di lavoro in accordo con i propri valori. Secondo la contributor Federica Celeste, manca però una legislazione nazionale che dia una spinta decisiva nell'adozione del principio tra le comuni politiche DEI delle aziende
di Federica Celeste*
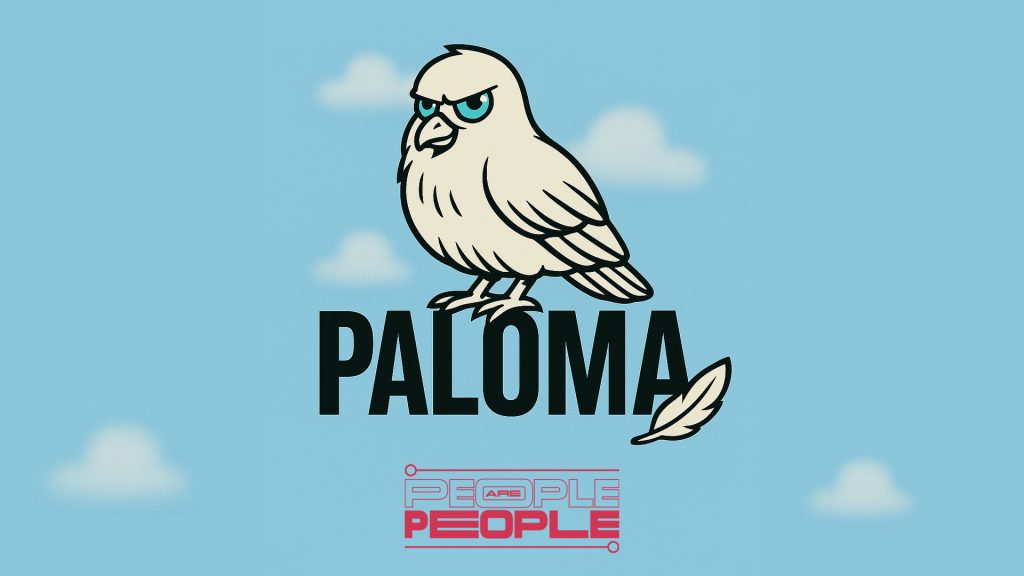
C’è uno strumento di inclusione che tutela la dignità della persona, riduce i rischi di outing forzato o discriminazioni, e migliora il benessere organizzativo e la sicurezza psicologica: la carriera alias. Si tratta di un accordo interno che permette a una persona transgender o non binaria di essere riconosciuta all’interno dell’ambiente scolastico o lavorativo con un nome e/o un genere diversi da quelli anagrafici, senza dover attendere il completamento dell’iter legale di rettifica dei documenti. Viene creato un profilo alternativo “alias” per l’uso interno in e-mail aziendali, badge, liste ufficiali, registri, comunicazioni interne, etc, che riportano il nome e il genere scelti dalla persona.
Non esiste ancora una legge nazionale che obblighi le aziende o le scuole italiane ad attivare la carriera alias: ogni ente o azienda decide autonomamente. Tuttavia, chi promuove questa misura di solito lo fa nell’ambito di politiche Diversity, Equity, Inclusion (DEI) avanzate e per evitare discriminazioni (obbligo previsto da normative generali su salute e sicurezza nei luoghi di lavoro, come il D.Lgs. 81/08 e il Codice delle Pari Opportunità).
In Italia e, in parte, anche a livello internazionale, molte realtà più virtuose sul fronte DEI hanno adottato o stanno adottando procedure di carriera alias per dipendenti, clienti e studenti. Le organizzazioni più impegnate su politiche di inclusione delle persone LGBTQIA+ hanno annunciato programmi di Diversity Management, dotandosi di policy specifiche per l’identità di genere. Eppure, in numerosi altri contesti, il riconoscimento della gender identity è ancora un tabù o un vezzo, non una tutela prioritaria.
È un privilegio potersi chiamare col proprio nome senza che nessuno chieda spiegazioni, eppure in Italia solo il 10% delle aziende offre una procedura chiara di carriera alias. Le altre organizzazioni si arrangiano: silenzi, mezze verità e mobbing sottopelle. La difficoltà è sempre colpa del diverso, mai dell’apparato che ha imposto quelle clausole scritte in piccolo secondo cui non è possibile rettificare l’indirizzo e-mail aziendale a causa della burocrazia.
L’alias è il nome che scegli quando quello anagrafico ti tradisce. Quando la tua identità viene appesa a una lettera su un tesserino aziendale come una condanna a morte sociale. Nel 2025, l’Italia delle pari opportunità è ancora uno slogan con una trappola a trabocchetto del tipo: «Possiamo usare solo il cognome, così nessuno si accorge». O, ancora: «Se poi vuole cambiare genere sui documenti, torni quando ha la sentenza».
«Il diritto all’identità personale è inviolabile», recita la Costituzione Italiana all’articolo 2, ma se vuoi lavorare, pagare l’affitto e campare, spesso resti zitto al tuo posto. Se ti lasci schedare dalla paura, come nessun manuale HR consiglierebbe, esisti, ma fuori dall’orario di lavoro, e ti senti pure più fortunato di chi sta peggio.
Storie che non consolano sono quella di Zoe, che si presenta al colloquio in giacca e cravatta. Curriculum impeccabile, stretta di mano sicura. Poi la domanda politicamente scorretta. Posta con quel sorriso sornione, come a sottolineare la piena liceità della stessa: «Scusi, lei è maschio o femmina? Sa, per il front office l’immagine è importante. Siamo un’azienda inclusiva, ma lei ovviamente non ha intenzione di esibire comportamenti troppo… visibili, vero?».
Anche quella di Michela, 29 anni, data analyst. Prima di ottenere un colloquio in cui la chiamassero col suo nome, ha mandato 120 CV. Con quello anagrafico? Ne bastavano 10. Andrea, 45 anni, responsabile commerciale. Licenziato “per incompatibilità ambientale” dopo la transizione. Nessuna causa legale: «Non avevo più energie. Volevo solo respirare».
Durante un colloquio, se speri che ti assumeranno solo risultando (o sembrando) abbastanza “normale” per non disturbare l’arredamento, ti aspetteranno mesi infernali. La carriera alias non è una concessione, ma una questione di dignità. Così come il diversity management non è una cortesia, ma un diritto civile. Non serve ringraziare, né chiedere scusa per la propria identità.
Le persone transgender o non binarie che iniziano a lavorare con documenti che non corrispondono alla loro identità vivono ogni giorno in una contraddizione: essere chiamati con un nome che non li rappresenta, firmare contratti con un’identità passata, dover spiegare ogni volta chi si è davvero. È stressante, alienante e invalidante rispondere al passato, mentre si prova a vivere il proprio presente.
La carriera alias permette che nei sistemi aziendali (badge, e-mail, organigramma) venga usato il nome scelto dalla persona, anche prima che l’anagrafica legale venga aggiornata. Non si tratta di un vezzo burocratico ma di un salvavita psicosociale. Ben diverso dai benefit aziendali, bensì un diritto di fatto, anche quando il diritto formale ancora latita.
Di frequente si scivola nel linguaggio della concessione: «Ti permetto di», «ti vengo incontro», «ti includo». Eppure, non è il lavoratore a dover adattare la sua identità al contesto, ma il contesto a dover garantire dignità all’identità.
In questo senso, il riconoscimento della carriera alias è un atto minimo di civiltà organizzativa, nel rispetto delle unicità e delle differenze: non l’adattamento dell’individuo al sistema, ma una progettazione sistemica inclusiva che prevenga discriminazioni strutturali.
Il benessere passa prima di tutto dal riconoscimento identitario. Perché nessuno può lavorare bene se prima deve nascondersi per lavorare. Chi oggi vive una carriera da alias lo fa spesso in silenzio, con gratitudine malcelata per quelle aziende che tollerano, anziché garantire. Non una esistenza piena, ma una sopravvivenza travestita da ciò che non si è più.
Sempre più realtà, grazie anche al lavoro congiunto di diversity e disability manager, associazioni, attivistə e alleatə, stanno trasformando le policy in pratiche e le pratiche in cultura. Non un favore, ma una misura concreta di benessere organizzativo, di salute psicologica. Perché chi si sente rispettato lavora meglio, resta più a lungo e si espone con più fiducia.
Se un’azienda intende adottare formalmente il protocollo alias per personale e studenti occorrono policy interne per garantire l’identità alias nei sistemi aziendali. Occorre chiarire modalità, responsabilità e garanzie tra HR e IT per gestire i sistemi interni (badge, e-mail, CRM) e verificare che anche fornitori esterni e app di gestione abbiano accesso al sistema alias. Per garantire la riservatezza, meglio interfacciarsi con un referente unico. In parallelo, è bene dare la priorità ad iniziative di formazione e sensibilizzazione per prevenire micro-aggressioni e discriminazioni.
Se stai vivendo una carriera da alias senza tutele non è colpa tua, se il contesto è in ritardo: non sei solə. Stanno nascendo reti, policy, alleanze. E puoi chiedere, con forza e dignità, ciò che ti spetta: essere riconosciutə, non tolleratə. Non vogliono vederci? Allora saremo impossibili da ignorare. Non è coraggio, ma fame di esistere anche a costo di disobbedire, Palome.

* Chi è l’autrice
Pedagogista delle organizzazioni e ingegnera gestionale, Federica Celeste è ricercatrice internazionale per il Politecnico di Milano. Oggi si occupa di formazione, benessere e gestione del cambiamento, dentro e fuori le aziende. Con un’anima divisa tra i numeri e le crepe psicologiche delle persone, le piace indagare il lato oscuro, ambiguo e tagliente delle storture lavorative. Appassionata di cinema e attivista per i diritti umani e animali, crede in un’idea di sostenibilità informata, anche se sa benissimo dove finiscono le buone intenzioni quando si scrive un post su LinkedIn.
Paloma nasce proprio dal suo bisogno di non smettere di metterci il cuore, mettendoci però il becco. Troppo giovane per essere vecchia, troppo vecchia per essere giovane, scrive e lavora da quell’età di mezzo in cui la lucidità è un superpotere. E anche una condanna.
NEWS CORRELATE