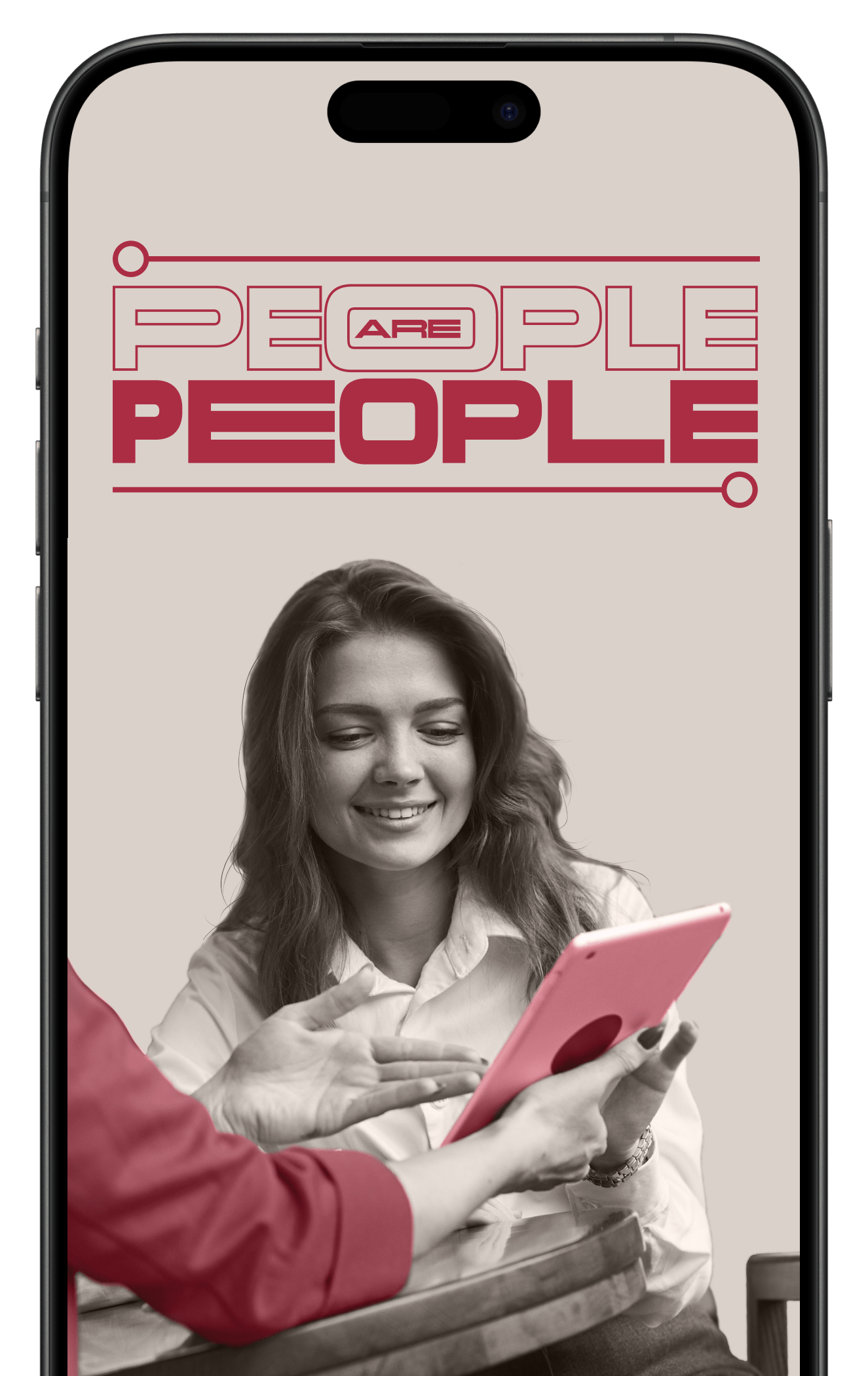Riccarda Zezza: «Riportiamo la cura al centro di ogni discorso sul lavoro»
Nella nostra intervista l'ideatrice di Lifeed spiega perché è urgente e doveroso riportare al centro di ogni discorso sul benessere al lavoro la parola che dà titolo al suo libro edito da Franco Angeli.
di Alessandra Cicalini
Voci del lavoro nuovo è la collana di Franco Angeli diretta da Silvia Zanella dedicata ai temi emergenti della nostra epoca, percorsa da crisi continue, nella politica, nell’economia, nella società e in noi stessi. Cura è la parola che Riccarda Zezza ha scelto come titolo del suo libro, per illustrare come e quando la medesima è stata espunta dall’ambito lavorativo, finendo per essere confinata alla sfera privata, ossia all’esclusivo terreno delle relazioni con amici, figli e genitori. All’ideatrice di Lifeed, protagonista dell’intervista che segue, interessava soprattutto spiegare, in maniera anche molto concreta e operativa, perché sia invece necessario e urgente recuperarla e riportarla, questa sì, al centro di ogni discorso sul benessere delle lavoratrici e dei lavoratori.

Riccarda, partirei dalla definizione di “transilienza”, da lei già utilizzata nel precedente libro dedicato alla maternità, con una piccola provocazione: acquisendo un superpotere così forte, non c’è il rischio di cominciare a guardare colleghe e colleghi (ma anche cape e capi) come bambine e bambini, trattando da pari a pari solo chi tra loro è diventato genitore?
«Direi di no… La transilienza non è un “patentino per genitori”! Piuttosto, è una meta-competenza (transizione + resilienza) che allena il passaggio consapevole di risorse fra i nostri ruoli: identifico un tratto/competenza dove sono forte, lo traduco in comportamenti e lo sperimento “mutatis mutandis” in un altro contesto.
Il rischio di infantilizzare colleghi o capi nasce quando la cura scorre in una sola direzione: nel lavoro, invece, la cura è relazione a due vie tra adulti e distribuisce potere e responsabilità (l’opposto della dinamica “manager babysitter/collaboratore-bambino”). Non “portiamo la famiglia in ufficio”: trasferiamo comportamenti universali (ascolto, chiarezza, gestione dello stress) che chiunque può allenare – che provengano dall’essere atleta, volontaria, amica o, sì, anche madre/padre».
Avete analizzato anche in termini numerici i risultati raggiunti dall’applicazione di questo metodo?
«Sì: su oltre 70.000 persone, la transilienza ha permesso di raddoppiare le competenze disponibili nei ruoli e l’80% dichiara di volerla usare nella vita quotidiana; dove emergono dubbi (contesto, “appropriatezza”), il punto è aggiornare definizioni e culture organizzative. In breve: la transilienza non crea una serie A dei genitori; allarga l’identità professionale e rende le relazioni più simmetriche. È un modo di prendersi cura che fa crescere sia chi la esercita sia chi la riceve».
“Ora et labora” è una delle frasi da lei citata per ricordare che è esistito un tempo in cui si metteva cura in ciò che ci garantiva il pane quotidiano. Dalla smaterializzazione del lavoro non si torna indietro, ma quand’è che da essere un vantaggio della modernità si è invece trasformata in insidiosa alienazione?
«La frase da lei ricordata teneva insieme tre dimensioni del lavoro: ciò che produce, le relazioni che genera e l’identità che costruisce. La smaterializzazione è stata un vantaggio finché non ha reciso le ultime due, riducendo il lavoro a pura prestazione e metri di produttività.
Il passaggio all’alienazione è avvenuto quando la tecnologia ha dissolto i confini e abbiamo perso il senso del tempo: dopo la “grande interruzione” della pandemia, siamo tornati a correre più di prima, connessi ovunque, ma senza manutenzione del significato. Il lavoro è entrato in casa; le persone, però, sembrano essere uscite di scena».
In questo scenario, il nostro Paese come si colloca?
«I segnali sono chiari: Italia ultima per engagement (5%), tristezza al 27%, stress al 49%, e un burnout che l’OMS definisce come esito di stress cronico non gestito; culture tossiche e “effetto spettatore” normalizzano l’indifferenza. Se ciò che conta è solo ciò che misuriamo, e la cura resta fuori dalle metriche (pur con timidi aggiornamenti nell’“S” di ESG), l’alienazione diventa sistema.
Che le chiamiamo “quiet quitters” o “great resignation”, queste definizioni fanno del lavoro un male necessario invece della manifestazione della volontà e del sogno della specie umana. Ma quando è diventato normale pensare che il lavoro renda infelici»?
L’effetto di questa anormalità normale si riflette anche nell’alto turnover, di cui raccontiamo spesso, anche sulla webtv. Il suo testo, però, offre anche strumenti pratici per fronteggiare un presente così poco incoraggiante. Mi riferisco in particolare agli esercizi che propone nei suoi percorsi di transilienza, basati sul trasferimento di ciò che si apprende nei propri ruoli al lavoro a ciò che si fa come madri/padri, caregiver, sorelle, figlie/i, e viceversa. A suo avviso, quale tipo di passaggio funziona meglio: il passaggio dal lavoro alla vita privata o oppure l’inverso?
«Entrambe le direzioni funzionano, ma se l’obiettivo è accendere consapevolezza sull’importanza della cura, il passaggio vita → lavoro (e società) è forse più critico: nei ruoli affettivi la cura è già “allenata”; trasferirla nel ruolo professionale la rende visibile, legittima e subito utile (ascolto, chiarezza, gestione dello stress). Nel programma di Lifeed con 58 manager, portare tratti “di cura” nel lavoro ha cambiato la loro stessa definizione di leadership (+calma, +premura, +sicurezza, +non-convenzionalità).
Il flusso lavoro → vita resta prezioso, ma sembra agire più sul lato cognitivo (gestione della complessità, pensiero critico, riduzione dell’ansia): utile a “stare meglio” a casa, con un effetto sulla cura più indiretto e graduale.
In pratica: partire da vita → lavoro con un comportamento universale concreto (es. micro-check di ascolto, una chiusura chiara della riunione) e poi fare ping-pong tra i ruoli per stabilizzare il cambiamento. È così che la transilienza rende la cura un’abitudine, non l’oggetto di facili e pericolosi stereotipi».
Chi ha o avrebbe più bisogno di esercitarsi con la transilienza: i capi o i collaboratori?
«Più urgente nei capi, per effetto leva: quando una leader allarga il proprio sé e trasferisce comportamenti di cura nel lavoro, cambia il modello di leadership e rende legittime nuove pratiche per tutti.
Indispensabile anche nei collaboratori, per passare da “esecutori” a corresponsabili: la transilienza li allena ad attivarsi, a prendersi spazio con misura – un po’ come il caregiver che rinegozia il rapporto con il genitore; nel lavoro questo significa saper intervenire, assumere responsabilità e anche fare un passo indietro quando serve.
In sintesi: parte dai capi per aprire lo spazio, si consolida nel team per far circolare potere e cura in due direzioni. Altrimenti resta un gesto individuale o calato dall’alto».
A suo avviso, quanto contano leggi come quella sul congedo parentale per stimolare la società nel suo complesso sull’importanza di prendersi cura gli uni degli altri?
«Contano molto, perché creano tempo e legittimazione sociale: dicono che prendersi cura non è un favore ma un diritto/dovere condiviso. Però, da sole, non bastano: dove esistono, il congedo retribuito è il benefit più usato ma lo utilizza solo il 55% degli aventi diritto, mentre il 52% dei datori neppure monitora le responsabilità di cura, segno che l’infrastruttura c’è, ma l’uso resta parziale.
Per attivare davvero la società, la norma va “tradotta” in pratica equa e non penalizzante per tutti: non solo per le madri (un terzo degli uomini cambia lavoro quando nella vita entra una responsabilità di cura), e includendo l’intero spettro del caregiving: figli e anziani, la cosiddetta generazione sandwich».
In aggiunta alle leggi che cosa servirebbe, allora?
«Le rispondo elencandogliele una per una.
In primo luogo, occorre parità di utilizzo e zero stigma, ossia valutazioni e carriere disegnate perché l’uso dei congedi non diventi una “penalità”.
In secondo luogo, serve flessibilità reale (orari/luoghi/rituali di inizio-fine) per rendere praticabile la cura senza fratture con il lavoro.
Terzo punto, bisogna misurare ciò che conta: tasso di fruizione dei congedi, qualità dei rientri, impatto su turnover, assenteismo e “presenteismo” (costi nascosti oggi altissimi).
Detto in breve: la legge apre la porta, ma sono cultura e pratiche organizzative a far entrare davvero la cura e a distribuirne i benefici».
Che cosa pensa dei percorsi psicologici nei luoghi di lavoro per tutti, non dico obbligatori, ma da consigliare fortemente?
«Dico di sì, ma non come prima mossa.
I percorsi psicologici aiutano – alleviano sintomi, danno linguaggio e strumenti – però curano a valle. Il problema nasce a monte, nel modo in cui oggi organizziamo il lavoro: confini dissolti, relazioni deboli, identità compresse. Lì serve il cambio di paradigma: transilienza e cultura della cura come prevenzione primaria. Anche in questo caso, le propongo uno schema, basato su tre livelli.
Il primo è la Prevenzione, ossia: rituali di confine, chiarezza di ruoli/aspettative, Universal Behaviours allenati con la transilienza (vita ↔ lavoro).
Il secondo livello è il Sostegno non clinico, ossia coaching/peer group brevi orientati alla pratica (feedback, check-in, gestione dello stress).
Il terzo livello prevede l’Intervento clinico, cioè psicoterapia/EAP facoltativi, con accesso facile, anonimato, tempo protetto e zero stigma».
Niente obbligo, in sostanza?
«Esatto: obbligarli rischia di medicalizzare ciò che è disegno organizzativo. Prima progettiamo contesto e competenze di cura; poi offriamo supporto psicologico come diritto, non come stampella».
Bellissime le definizioni di cura come “sguardo” e come “relazione”: come si collega il primo, che sembrerebbe un’attitudine più individuale, con la seconda?
«Lo sguardo è il primo superpotere della cura: etimologicamente rimanda al “guardare/porre attenzione” e interrompe la nostra cecità attenzionale: tutto ciò che non vediamo perché lo diamo per scontato. Accendere la cura significa allargare il cono di luce su persone e contesto: non guardo e basta, punto lo sguardo.
Bastano infatti meno di 40 secondi di attenzione piena perché cambino gli esiti della relazione (e anche il nostro modo di sentirci): è il “costo” dell’attivazione dell’empatia. E c’è anche una base biologica: siamo “cablati per la cura”. I neuroni specchio ci predispongono infatti a rispecchiare azioni ed emozioni; sotto stress, oltre ad “attacco o fuga”, la specie umana possiede un altro istinto primario, quello del tend & befriend (allearsi e prendersi cura).
Operativamente, il collegamento tra cura e relazione è insomma dato da una catena di cinque superpoteri: dallo sguardo (vedere) al sentire (empatia/compassione), al fare (un’azione), al fare bene (qualità, rigore), fino al pensare (nuove mappe e decisioni). La relazione nasce quando lo sguardo innesca gli altri quattro: vedo → sento → agisco → curo la qualità → ripenso le possibilità di ciò che faccio».
Come si tengono uniti i piani, quindi?
«Servono tre micro-passaggi pratici: il primo è “Vedo”, cioè metto a fuoco un fatto osservabile (“ho notato X…”) invece di un’etichetta.
Il secondo è “Nomino”, ossia do un nome a ciò che ho visto (riconoscimento specifico), ed è già relazione. Il terzo è “Agisco”, quindi faccio un gesto, anche piccolo, ma coerente (ascolto, chiarezza, chiusura di una riunione) e mi prendo la responsabilità del suo effetto».
Sentendola parlare, sembra tutto molto semplice, e invece, come scrive, stiamo diventando incapaci di prenderci cura innanzitutto di noi stessi, nonostante il bombardamento continuo soprattutto sui social di percorsi di mindfulness e altre strategie per “ri-centrarci”. Come se la spiega una contraddizione del genere?
«Che cosa ci frena dal prenderci cura di noi stessi, che cosa ci fa paura nella relazione tra noi e noi? Innanzitutto, abbiamo paura di vedere noi stessi veramente, che è l’unica precondizione necessaria al prendersi cura: possiamo prenderci cura di qualcuno solo se lo vediamo davvero, con uno sguardo che accoglie “tutto”.
Uno sguardo del genere è molto diverso da quello che ci riflette falsati e parziali nei social e nell’immagine che vorremmo gli altri avessero di noi: assomiglia piuttosto allo sguardo di una madre su un neonato, che vede tutto e lo trova comunque e sempre prezioso.
Lo sguardo della cura è capace di accogliere le fragilità. Eppure, è così difficile volerci vedere fragili. Per questo, la prima persona che trascuriamo è quella con cui viviamo ogni giorno: la diamo per scontata, la trasciniamo tra le urgenze. Eppure, sono i suoi occhi a misurare il mondo, la sua voce a parlare per noi, il suo cuore a reggerci. Così, anche ora che ci specchiamo continuamente negli schermi, quella faccia ci resta estranea: non mancano le immagini, manca la visione. La prima crisi della cura è qui: nello sguardo limitato che rivolgiamo a noi stessi. Per questo nel libro propongo di cambiare domanda: prima ancora di “Come stai?”, domandare: «Ti prendi cura di te stesso?», come faceva Socrate».
Oltre alla parola cura, nelle conclusioni ha scritto amore, grazia, passione, dedizione, tutti vocaboli che ci esorta ad utilizzare al lavoro. Al di là del mio grazie personale per averle usate, quanto è importante secondo lei che anche le organizzazioni mettano “nero su bianco” i loro valori per dare reale senso al loro business: in altri termini, crede nel “purpose” come strategia di cura da parte di chi produce?
«Sì, ci credo se diventa cura operativa, concreta. La cura non è in ciò che facciamo, ma in come lo facciamo: per questo i valori contano solo quando orientano gesti, decisioni e relazioni, non quando restano slogan.
Nelle conclusioni invito a rimettere passione, amore, dedizione, grazia nel lavoro come scelta che ridà senso ai gesti quotidiani e contenuto alla strategia dell’impresa. È così che torniamo a “lavorare con amore” e, attraverso il lavoro, a prenderci cura del mondo.
“Mettere nero su bianco” serve solo se trasforma il potere in responsabilità. In breve, il purpose è una strategia efficace di cura quando allinea identità, pratiche e risultati; quando cambia definizioni e metriche e allarga lo sguardo sulle persone nella loro complessità».
Come sta andando la diffusione del libro?
«Bene: sta generando conversazioni concrete. Molti lettori mi hanno scritto che si sono sentiti “visti” e hanno portato un nuovo gesto di cura nel lavoro già il giorno dopo».
Ha ricevuto anche sollecitazioni nuove dai lettori?
«Sì, ad esempio come spezzare l’indifferenza nei team quando “tutti vedono, nessuno interviene” (effetto-spettatore); come dare spazio a parole e gesti che oggi la cultura aziendale scoraggia in nome dell’efficienza; come introdurre micro-rituali e responsabilità condivise senza aggiungere burocrazia».
C’è qualche SOS ricorrente da parte di chi la legge?
«Sì: tra quelli più diffusi, ci sono per esempio manager che chiedono strumenti per passare da monologhi a relazioni a due vie; team che vogliono criteri semplici per riconoscere e nominare la cura; persone che cercano un modo sicuro per portare tratti “di vita” nel ruolo professionale e in questo caso, come dicevo prima, la leva è la transilienza, che ci permette piccoli trasferimenti, osservabili e ripetibili, che cambiano i tratti con cui descriviamo il nostro ruolo».
I feedback ricevuti stanno modificando anche le azioni della sua azienda?
«Sì anche in questo caso: in Lifeed sono già diventati kit di micro-pratiche di transilienza per capi e team, linee guida anti-bystander e focus sulle “regole non dette” che oggi rendono onerosa la cura. In sintesi, il libro ci ha permesso di passare dalle parole ai gesti, ed è lì che vogliamo continuare a lavorare con le aziende, che possono essere piccoli ecosistemi di cura e potere».
NEWS CORRELATE