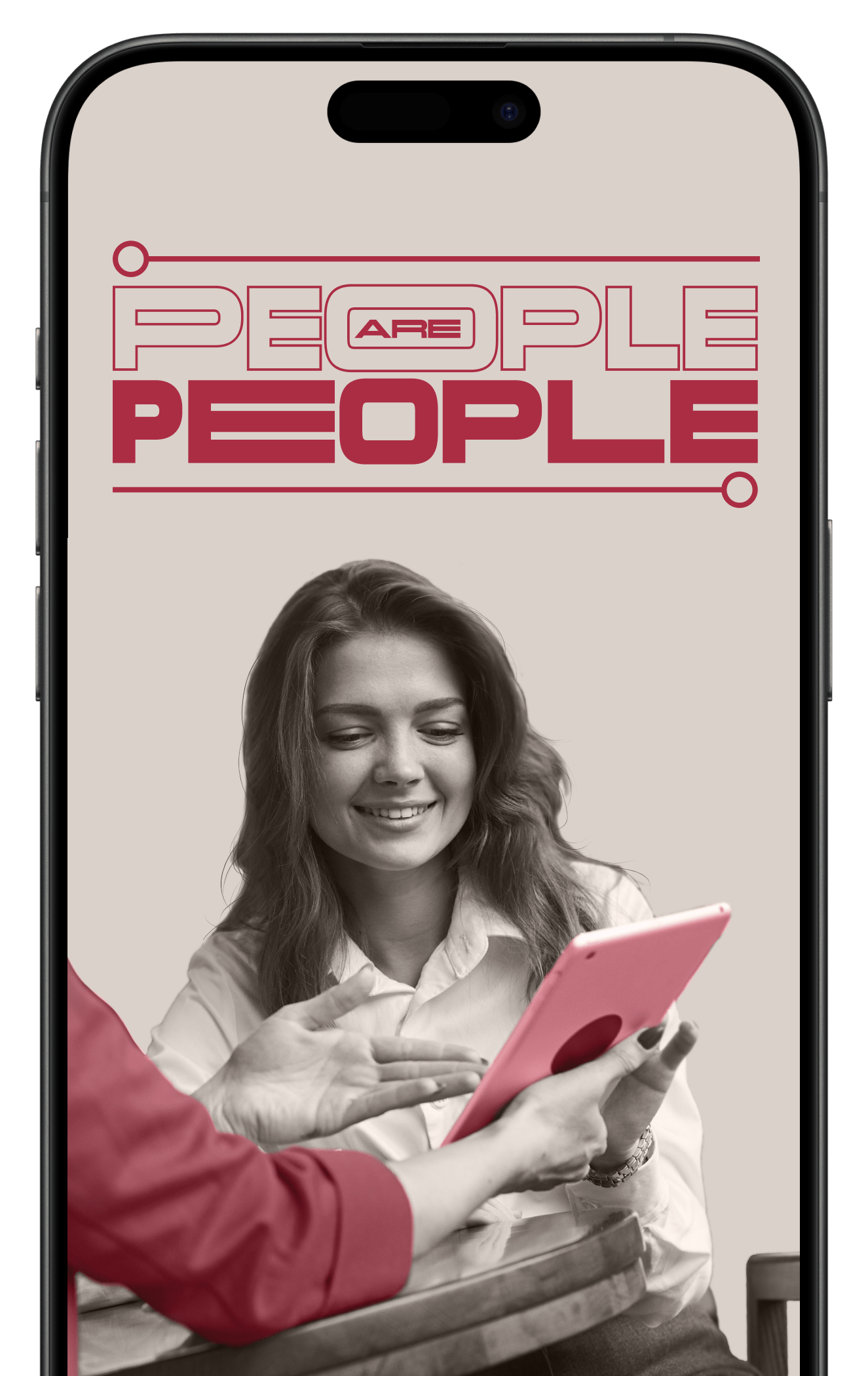Gender mainstreaming, strategia di reale parità di genere. Da non sprecare
Stop ad ogni tentazione di "pinkwashing" grazie all'adozione di un modello di azioni pubbliche pensato in maniera consapevole ed equa per donne e uomini. Ne parla la contributor Federica Celeste nel suo nuovo articolo.
di Federica Celeste*
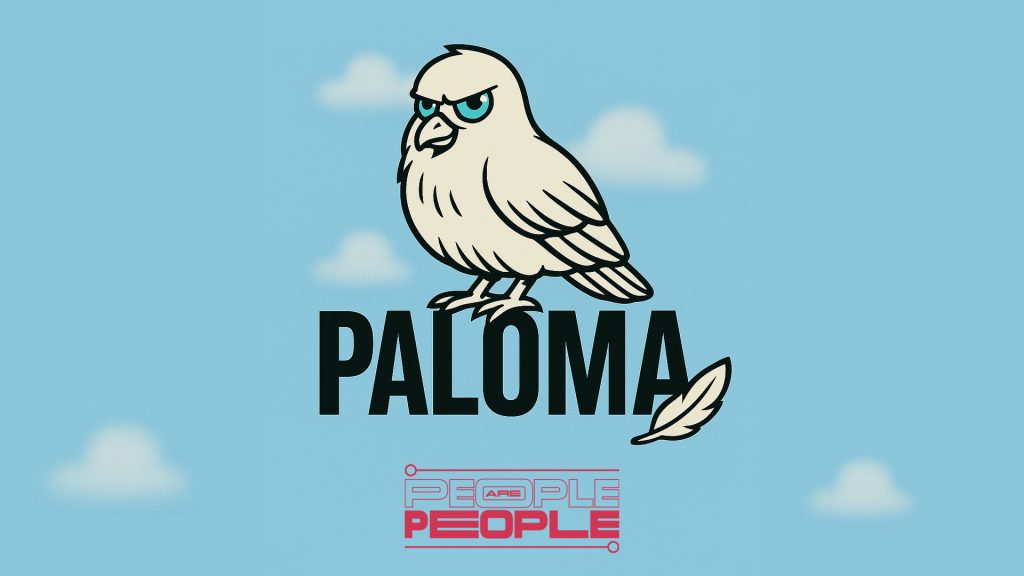
Per anni, la parità di genere è stata un tema da convegno: buoni propositi, piani triennali, fotografie stock di mani diverse che si stringono.
Poi qualcosa è cambiata nel contesto europeo grazie al gender mainstreaming. Di cosa si tratta?
Il gender mainstreaming è una strategia politica e amministrativa che mira a integrare la prospettiva di genere in tutte le fasi delle politiche pubbliche, dalla progettazione all’attuazione, dal monitoraggio alla valutazione.
Un approccio trasversale per evitare di creare politiche separate per donne e uomini, ma considerare sistematicamente gli effetti che ogni decisione può avere sui generi, con l’obiettivo finale di raggiungere l’uguaglianza sostanziale e non solo formale.
Il concetto è stato ufficializzato nel Programma di Azione della Conferenza Mondiale sulle Donne di Pechino trent’anni fa (ONU, 1995). Da allora, è stato adottato da numerosi organismi internazionali, tra cui l’Unione Europea, che lo considera una strategia chiave per attuare la parità.
Nel concreto, il gender mainstreaming funziona più o meno così:
– analisi di impatto di genere, prima di approvare una legge o una politica, si valuta se avrà effetti diversi su donne e uomini;
– raccolta dati disaggregati per sesso, per capire realmente come una misura incide sui diversi gruppi;
– budgeting di genere, verificando come vengono distribuite le risorse pubbliche e se ci sono disparità;
– formazione dei decisori, per sensibilizzare funzionari, politici e stakeholder alla dimensione di genere.
Oggigiorno l’integrazione sistematica della prospettiva di genere in ogni fase di elaborazione delle politiche pubbliche è diventata criterio di accesso ai finanziamenti.
È entrata nei bandi Horizon Europe, nei programmi nazionali di riforma, nei PNRR, nei fondi di coesione. Non parliamo più solo di welfare o pari opportunità, bensì di trasporti, urbanistica, AI, fiscalità, difesa.
Scendendo ancora più nello specifico, la prospettiva di genere è centrale se si cerca di rispondere a domande del tipo: come cambia un progetto di smart city se si analizza chi utilizza i trasporti pubblici e come? Come si ripensano gli algoritmi di intelligenza artificiale quando ci si accorge che i dataset sono maschili per il 78%? Che impatto hanno le politiche fiscali sui carichi di cura non retribuiti, ancora perlopiù femminili?
Queste domande oggi pesano, perché portano soldi o li tolgono e per troppi questo è ancora un tabù.
Un esempio pratico per Palome sensibili all’applicabilità quotidiana è quando una città decide di estendere il trasporto pubblico serale. Prolungare l’orario dei mezzi pubblici fino a tarda sera apparentemente è una buona notizia per tutti. Ma il gender mainstreaming impone una domanda cruciale: questa misura risponde anche ai bisogni specifici di donne e uomini in modo equo?
La risposta è sì, se migliora la sicurezza e l’accessibilità per le donne nei casi in cui:
– le donne che lavorano su turni (in sanità, retail, ospitalità) potranno tornare a casa senza dipendere da un partner o da un’auto;
– le ragazze che frequentano corsi serali o università saranno più autonome negli spostamenti, con un impatto positivo sulla formazione;
– le madri single o le donne con reddito basso, spesso meno motorizzate, potranno spostarsi in modo più economico e sicuro;
– sono previsti punti ben illuminati, videocamere, personale di bordo o fermate su richiesta, accrescendo l’effetto positivo sulla percezione e sulla reale sicurezza.
In questi casi, allora la misura sostiene l’autonomia femminile, l’occupazione e l’accesso paritario ai servizi. Al contrario, non sarebbe coerente con il gender mainstreaming se:
– i mezzi passassero solo su rotte centrali e maschili (es. zona stadi, uffici, centri congressi), trascurando i quartieri residenziali dove vivono molte donne;
– non ci fossero misure per contrastare molestie sui mezzi o nelle fermate;
– non venisse consultata la cittadinanza per sapere chi ha bisogno del servizio e come.
In questi casi, la misura rischierebbe in definitiva di essere neutra solo in apparenza, e inefficace o discriminante nei fatti.
Dunque, la domanda da porre non è: «Quanti autobus in più mettiamo?», ma: «Chi userà questi autobus? In che condizioni? Cosa serve perché tutte le persone si sentano sicure e libere di farlo?».
Detto in altri termini, se un principio non contribuisce a un cambiamento strutturale va ripensato per non scadere nel pinkwashing, una strategia comunicativa con cui istituzioni, aziende o governi promuovono iniziative che sembrano femministe o inclusive, ma che in realtà non producono cambiamenti concreti o mascherano pratiche discriminatorie.
Le norme e le politiche apparentemente neutrali spesso producono effetti diseguali.
Come un bonus per le auto aziendali può favorire più gli uomini, se sono loro a detenere più frequentemente ruoli dirigenziali.
Il rischio di retorica e difficoltà di implementazione richiede competenze, dati e volontà politica. Ancora oggi, parlare di genere è visto come ideologico da alcuni ambienti a causa delle resistenze culturali.
Eppure, il gender mainstreaming non è una “politica per le donne”, bensì una politica per migliorare la qualità delle decisioni, rendendole più eque, inclusive ed efficaci.
Il gender mainstreaming europeo non è un fiocco rosa messo a margine. È una leva sistemica che allena (e costringe) governi, regioni, aziende a imparare un nuovo mestiere: pensare con il cervello intero, non solo con quello che somiglia a chi decide.
Naturalmente, persisterà il rischio dell’effetto check the box dei documenti scritti per accontentare i revisori, senza cambiare davvero i processi. Come direbbe Nancy Fraser: non basta redistribuire, serve anche riconoscere.
Ma la pressione aumenta. E ogni nuova direttiva e ogni nuova raccomandazione spingono un po’ più in là la soglia di ciò che viene considerato “neutrale”.
Perché neutrale non esiste: ogni policy, ogni tecnologia, ogni sistema è progettato da qualcuno, per qualcuno.
Così il gender mainstreaming europeo delinea due strade per chi lavora nelle organizzazioni complesse: trattarlo come adempimento obbligatorio, sperando che passi il vento oppure capirne la portata politica e strategica, e usarlo per progettare un cambiamento che oggi, finalmente, può avere legittimazione normativa ed economica. Da Palome, scommettiamo su quale scelta sarà più lungimirante?
Alleniamo il nostro volo non solo a fare di più, ma a fare meglio e con maggiore consapevolezza.

* Chi è l’autrice
Pedagogista delle organizzazioni e ingegnera gestionale, Federica Celeste è ricercatrice internazionale per il Politecnico di Milano. Oggi si occupa di formazione, benessere e gestione del cambiamento, dentro e fuori le aziende. Con un’anima divisa tra i numeri e le crepe psicologiche delle persone, le piace indagare il lato oscuro, ambiguo e tagliente delle storture lavorative. Appassionata di cinema e attivista per i diritti umani e animali, crede in un’idea di sostenibilità informata, anche se sa benissimo dove finiscono le buone intenzioni quando si scrive un post su LinkedIn.
Paloma nasce proprio dal suo bisogno di non smettere di metterci il cuore, mettendoci però il becco. Troppo giovane per essere vecchia, troppo vecchia per essere giovane, scrive e lavora da quell’età di mezzo in cui la lucidità è un superpotere. E anche una condanna.
NEWS CORRELATE